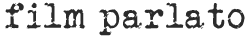Che cos’è il cinema?
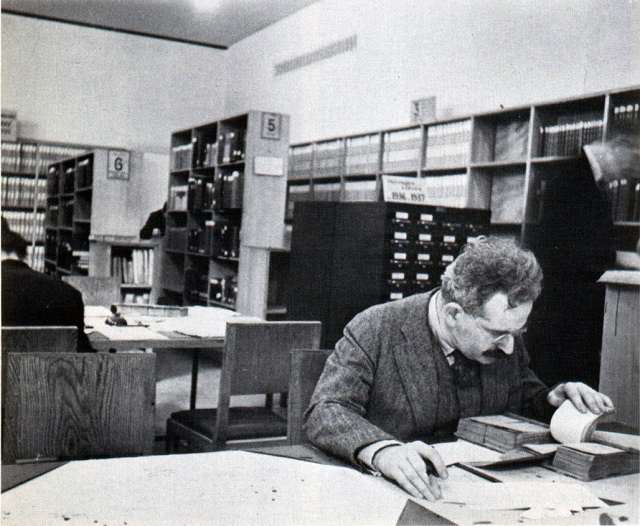 “Senza il cinema la decadenza dell’aura si farebbe sentire in una maniera non più sopportabile”. La frase arriva in coda – con un urto frontale del tutto imprevisto, come per un colpo di sonno alla guida o (Benjamin di sicuro, ma anche Godard, gradirebbe il paragone) l’assestarsi divinatorio di forme nei fondi di caffè. Ma del cinema, in questo lacerto intitolato Che cos’è l’aura? (rinvenuto qui: tre fogli di cm 18,5x11 provenienti da un blocco pubblicitario, v. Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avanzato, Neri Pozza 2012, da cui provengono tutte le citazioni a seguire in questo testo; e poi, negli ultimi drammatici mesi di vita, ripreso quasi per intero da Benjamin nella famosa seconda stesura Su alcuni motivi in Baudelaire), fino a quel momento non c’è traccia, di modo che la sua emersione, con quella maniera ironica e dura del Benjamin insieme notista e rivoluzionario, prevede o fa pensare a abissi spalancati su entrambi i lati, cioè prima e dopo la cosa scritta (modus operandi eminentemente vertoviano). A meno che non si voglia intravederlo (il cinema) sull’annotazione spaiata scritta sul margine superiore del primo foglio: “Essere guardati alle spalle / incontro degli sguardi / levare lo sguardo, ricambiare lo sguardo”. A posteriori, ma anche appunto in forma di veggenza lumièriana, diremmo che sì infatti c’è una lingua (che è la lingua) del cinema che non ha niente a che fare col modo tecnico e neppure col piano espressivo. Una lingua senza futuro, ossia inattualizzata al punto da segnalare l’illusorietà del passare di stagioni e epoche e insistere inesorabile a posizionarsi nel contemporaneo, per chi voglia misurarne (con annesso tremore) distanza, lontananza. “L’aura è il manifestarsi di una lontananza”. Quando tu vedi qualcuno o qualcosa levare lo sguardo per guardarti dai al tempo stesso la tua posizione e azioni una forma di trascinamento verso l’altro. Ora, i passi che si decidono di compiere in quella direzione o per restare fermi li chiamiamo film. E la danza naturale (nel peggiore dei casi – la stragrande maggioranza - autoritaria e fasulla, nel migliore zoppicante e conscia della varietà inconoscibile del cammino) attorno prima e dopo le immagini, si dirà proseguimento conflittuale del cinema nella parola. Sto dicendo che tutto quello che sappiamo dello scrivere di cinema (indipendentemente dai film!) lo si deve a Benjamin? Si, dal momento che “l’occhio desto non perde l’arte dello sguardo quando, in esso, il sogno si spegne. Al contrario, solo allora diventa davvero insistente”. I piccoli salti e i grandi abissi, le piccole e le grandi intuizioni, le striscianti pigrizie e i folli desideri, i vortici i nastri e le disseminazioni, le chiarezze le incomprensioni (ah, i punti di vista!) e le perdite di memoria, relative e subordinate, logorrea e balbettii, entusiasmi, passaggi a vuoto: ecco detta l’arte del film riscritto (ne consegue che riscrivere Benjamin significa parlare e scrivere di cinema? Si). Cercare di assomigliare allo sguardo di chi risponde al tuo sguardo: naturale reazione umana cui il cinema, sempre più flebilmente, assegna una voce, ma include anche la pazzia di essere tutte le voci. Ciò da un lato provoca dispersione e obsolescenza e la parola diventa al massimo insulso brusio; dall’altro allude alla possibilità di una trasformazione. Ciò “può a lungo dissimulare come sia diventato pericoloso vivere nella società umana” in stato di decadenza dell’aura, cioè nell’incapacità ormai di levare lo sguardo verso l’altro dando attenzione e donando la propria differenza e intensità, cosa che secondo Benjamin è alleviata (altrimenti sarebbe “insopportabile”) dal cinema (e cosa che tuttavia non ha evitato di lì a poco la Seconda Guerra Mondiale, e, visti i modi di circolazione dell’immagine e gli eventi macabri che si susseguono, meglio sorvolare sull’oggi). Ma se viviamo in una condizione di insopportabilità, a cosa si devono gli sprazzi di sopravvivenza che pur sussistono? E come fa il cinema a sopravvivere ai film? E se l’aura è quasi del tutto decaduta, il cinema è ancora a salvaguardia di qualcosa? Di Baudelaire diceva: “descrive occhi di cui si potrebbe dire che è andata perduta la capacità di guardare”, sapendo da subito che l’immagine in sé è il racconto non solo della perduta capacità di guardare ma di quello che sempre si perde (e ci si perde) guardando.
“Senza il cinema la decadenza dell’aura si farebbe sentire in una maniera non più sopportabile”. La frase arriva in coda – con un urto frontale del tutto imprevisto, come per un colpo di sonno alla guida o (Benjamin di sicuro, ma anche Godard, gradirebbe il paragone) l’assestarsi divinatorio di forme nei fondi di caffè. Ma del cinema, in questo lacerto intitolato Che cos’è l’aura? (rinvenuto qui: tre fogli di cm 18,5x11 provenienti da un blocco pubblicitario, v. Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avanzato, Neri Pozza 2012, da cui provengono tutte le citazioni a seguire in questo testo; e poi, negli ultimi drammatici mesi di vita, ripreso quasi per intero da Benjamin nella famosa seconda stesura Su alcuni motivi in Baudelaire), fino a quel momento non c’è traccia, di modo che la sua emersione, con quella maniera ironica e dura del Benjamin insieme notista e rivoluzionario, prevede o fa pensare a abissi spalancati su entrambi i lati, cioè prima e dopo la cosa scritta (modus operandi eminentemente vertoviano). A meno che non si voglia intravederlo (il cinema) sull’annotazione spaiata scritta sul margine superiore del primo foglio: “Essere guardati alle spalle / incontro degli sguardi / levare lo sguardo, ricambiare lo sguardo”. A posteriori, ma anche appunto in forma di veggenza lumièriana, diremmo che sì infatti c’è una lingua (che è la lingua) del cinema che non ha niente a che fare col modo tecnico e neppure col piano espressivo. Una lingua senza futuro, ossia inattualizzata al punto da segnalare l’illusorietà del passare di stagioni e epoche e insistere inesorabile a posizionarsi nel contemporaneo, per chi voglia misurarne (con annesso tremore) distanza, lontananza. “L’aura è il manifestarsi di una lontananza”. Quando tu vedi qualcuno o qualcosa levare lo sguardo per guardarti dai al tempo stesso la tua posizione e azioni una forma di trascinamento verso l’altro. Ora, i passi che si decidono di compiere in quella direzione o per restare fermi li chiamiamo film. E la danza naturale (nel peggiore dei casi – la stragrande maggioranza - autoritaria e fasulla, nel migliore zoppicante e conscia della varietà inconoscibile del cammino) attorno prima e dopo le immagini, si dirà proseguimento conflittuale del cinema nella parola. Sto dicendo che tutto quello che sappiamo dello scrivere di cinema (indipendentemente dai film!) lo si deve a Benjamin? Si, dal momento che “l’occhio desto non perde l’arte dello sguardo quando, in esso, il sogno si spegne. Al contrario, solo allora diventa davvero insistente”. I piccoli salti e i grandi abissi, le piccole e le grandi intuizioni, le striscianti pigrizie e i folli desideri, i vortici i nastri e le disseminazioni, le chiarezze le incomprensioni (ah, i punti di vista!) e le perdite di memoria, relative e subordinate, logorrea e balbettii, entusiasmi, passaggi a vuoto: ecco detta l’arte del film riscritto (ne consegue che riscrivere Benjamin significa parlare e scrivere di cinema? Si). Cercare di assomigliare allo sguardo di chi risponde al tuo sguardo: naturale reazione umana cui il cinema, sempre più flebilmente, assegna una voce, ma include anche la pazzia di essere tutte le voci. Ciò da un lato provoca dispersione e obsolescenza e la parola diventa al massimo insulso brusio; dall’altro allude alla possibilità di una trasformazione. Ciò “può a lungo dissimulare come sia diventato pericoloso vivere nella società umana” in stato di decadenza dell’aura, cioè nell’incapacità ormai di levare lo sguardo verso l’altro dando attenzione e donando la propria differenza e intensità, cosa che secondo Benjamin è alleviata (altrimenti sarebbe “insopportabile”) dal cinema (e cosa che tuttavia non ha evitato di lì a poco la Seconda Guerra Mondiale, e, visti i modi di circolazione dell’immagine e gli eventi macabri che si susseguono, meglio sorvolare sull’oggi). Ma se viviamo in una condizione di insopportabilità, a cosa si devono gli sprazzi di sopravvivenza che pur sussistono? E come fa il cinema a sopravvivere ai film? E se l’aura è quasi del tutto decaduta, il cinema è ancora a salvaguardia di qualcosa? Di Baudelaire diceva: “descrive occhi di cui si potrebbe dire che è andata perduta la capacità di guardare”, sapendo da subito che l’immagine in sé è il racconto non solo della perduta capacità di guardare ma di quello che sempre si perde (e ci si perde) guardando.